| |
|
|
|
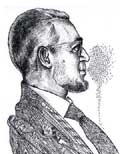 |
Ignazio
Apolloni |
|
| |
|
| STUDI
E TESTIMONIANZE |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| Antonino
Contiliano |
Aldo
Gerbino |
| Attilio
Lolini |
| Elisabetta
Mondello |
| Ugo
Piscopo |
| |
| |
|
Antonino
Contiliano
|
| |
Antigruppo
Siciliano
Frammenti di storia, avanguardia e impegno. pdf.
top |
|
| |
| |
| |
|
Aldo
Gerbino
|
|
Estratto
da “Storia della Sicilia”, volume ottavo, Pensiero e cultura
letteraria dell’Ottocento e del Novecento, Editalia – Domenico
Sanfilippo Editore, pagg. 601-602 e 604-605.
“Antigruppo”
e gruppi fra Trapani e Palermo. Maniera, impegno e canto
Tra
la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta le inquietudini
dei giovani raccolti attorno a Luciano Anceschi e alla celebrata rivista
«Il Verri», nonché al gruppo dei “novissimi”
(Sanguineti, Pagliarani, Porta e altri), vede Palermo quale polo della
sperimentazione letteraria, artistica, teatrale e musicale. Roberto
Di Marco, Michele Perriera e Gaetano Testa pubblicano con Feltrinelli
La Scuola di Palermo anticipando così la nascita del Gruppo ‘63
(il loro catecumenico convegno fu infatti registrato a Palermo nel 1963)
che ordinò il manipolo della sua avanguardia.
Non si riconobbero nella linea del Gruppo ‘63 alcuni giovani scrittori
e poeti siciliani i quali, nella seconda metà degli anni Sessanta,
costituirono l’Antigruppo (Crescenzio Cane, Ignazio Apolloni,
Pietro Terminelli, Nat Scammacca – principale animatore di cui
vanno ricordati tra i tanti testi: Ombre e luci, Glenlee, A Lonely room
–, Santo Calì, Rolan¬do Certa). Con essi ancora aderirono,
o vollero respirare quella atmosfera, scrivendo nelle ricche antologie
del tempo, raccolta in due ponderosi volumi (Antigruppo), autori quali
Carmelo Pirrera e Gianni Diecidue, espungendo i sentimenti di rivalsa,
troppo spesso vestiti del tono litigioso della provincia, con più
avvertite esigenze di autonomia sperimentativa e che avessero anche
la caratterizzazione del rispetto della territorialità culturale.
Figure prossime, quelle dell’Antigruppo, alle frange estremiste
dell’ideologia marxista, rappresentarono le caratteristiche icone
del sottoproletariato urbano. Molte le pubblicazioni di antologie, libri,
riviste, ma restarono (sin da quel confinato periodo e con qualche eccezione)
un fenomeno locale spesso con prove letterarie di esile valore, vestito
di un acceso epigonismo, come del resto simili fenomeni furono registrati
in altre aree del meridione italiano. Figura di spicco fu senza dubbio
Santo Calì, che, come riferisce N. Mineo, fece uso di una scrittura
dialettale la quale «non riproponeva certa¬mente valori del
passato per conservarne il senso e per proiettarli come futuro. La sua
è un’operazione di “inclusione” nel dialetto
dei valori più moderni e, poiché rivoluzionario era, dei
valori rivoluzionari». Un autore, un poeta che Mineo registra
dentro «una tradizione che ha – a monte – Porta e
Belli, cioè i poeti che hanno rivelato il mondo popolare non
come mondo folklorico ma come mondo di sofferenza, come mondo di dignità
umana». Ma con esso va evidenziata, per l’assunzione di
una identità autonoma forte¬mente inserita sul versante della
comunicazione e del fascino multimediale, la figura di Ignazio Apolloni
(vedi in questo volume) e, per il suo valore temporale, il centralismo
proletario nelle opere di Crescenzio Cane (Palermo 1930).
Da questo impegno, protrattosi sia sul piano di una vigile attenzione
nei confronti del linguaggio (Apolloni) sia del senso e del peso della
parola (Pirrera), proprio Carme¬lo Pirrera (Caltanissetta 1932)
consente negli anni la levitazione della sua scrittura attraverso un’intensa
attività pubblicistica (operata su scenari letterari del tempo
quale “Impegno 70” e “80”, il cui maggiore promoter
fu Rolando Certa, e soprattutto attraverso una riacquisizione dei termini
poetici ribaltando esperienze personali e collettive della sua area
d’origine (quella nissena), ricca di suggestioni e innervata da
un realismo profondamente coinvolto con il mito. L’espressione
di Pirrera, rivolta sul fronte della prosa sin dagli anni Settanta (La
ragazzata, 1972; Quaranta sigarette, 1974; Il colonnel¬lo non vuole
morire, 1974; Ipotesi sul caso Maiorana, 1981), è soprattutto
nella poesia che ritrova la sua dimensione più assorta (da Quartiere
degli angeli del 1968 a Que¬st’animale muore del 1976, da
Giocando con la polvere del 1982 a Il miele di maggio del 1985), più
partecipe sul piano delle emozioni e della consapevolezza. Ma l’attività
di agitatore culturale permane, dirigendo la piccola rivista «Issimo»,
con la redazione della poetessa Francesca Traina e di Pino Giacopelli
(di cui vengono segnalate tra le più recenti auto-pubblicazioni:
Mizar, L’Officina delle comete, Semi di rosaspiga, Flauto di cristallo,
Opus incertum, L’inevitabile accade sempre), o curando piccoli
volumi per le edizioni Il Vertice. Un’attività e un’identità
poetica, quella di Pirrera, attenta al vasto seme del respiro della
memoria e della realtà, dove vengono riconosciuti tra i padri
le figure indimenticabili di Vann’Antò e Calogero Bonavia.
Ignazio Apolloni. Oltre i confini della visionarietà
Se
dovessimo evidenziare il vasto ecumene letterario di Ignazio Apolloni
(Palermo 1932), potrebbe essere sufficiente il termine che Stefano Lanuzza
esprime nel testo di presentazione del suo più recente testo
di narrativa (Racconti patafisici e pantagruelici): «un brulichio
di figure burlesche, paesaggi sghimbesci, eventi tumultuosi e patetici,
anima questo libro connotato da uno spirito d’osservazione calcolatamente
disinvolto, ironico, frammentario, martellante, e antisistematico; oltre
che da un lessico autoreferenziale o discentrato dal senso: malizioso
e infido, inteso a significare un mondo che nella sua difformità
non ha confini né facili rifugi». Questi – continua
– «sono negati dall’autore sempre lesto a superare
con una battuta o un’arguzia qualsivoglia dialettica, temeraria
morale, sintesi subliminale, retorica epicità».
Visione e manualità, marchio e gesto, tracciati fono-idosemantici,
lettering e neo-chirografie, fanno di questo poeta (e scrittore) singlossico
e sperimentatore dell’anti-nonsense, di questo surreale costruttore
di libri lignei, distanziatosi dall’epigonismo manieristico di
cui è stato afflitto il Gruppo ‘63, un’autonoma voce
di ricerca. Interessanti e vivaci le sue «sketch-poesie»,
il cui «aspetto fondamentale», scriveva Rossana Apicella
(1979), «può essere identificato nella ricerca della singlossia
come coscienza e scelta di un modus, di una ratio operativi: Apolloni
non incontra occasionalmente la singlossia come un veicolo di comunicazione
che gli consenta di essere, agevolmente, «dans le vent»,
dal momento che, oggi, non è possibile essere neoteroi o novissimi
senza essere vecchissimi e desueti, ma è possibile solo essere
contemporanei nella reificazione di un linguaggio idofonosemantico».
Nell’uso della linea, del corpo simbolico, della parola assunta
come categoria o come oggetto drasticamente immerso nella sua più
impetuosa natura semantica, come nella continua deflagrazione operata
tra il signifi¬cante e il significato, e ancora attraverso quella
voluttà pronta a sostenere l’impeto del calembour, viene
consegnata alla visione scardinante di Apolloni una singolare ricchez¬za
di umori creativi. Di Ignazio Apolloni vanno ricordate le opere di narrativa:
Niusia (1965-68) e, dopo le esperienze delle Favole per adulti, i trentuno
racconti di Capelli¬no, il romanzo poetico-metafisico Roma 1956
e Gilberte (1997), raccoglie parte della sua poesia in Singlossie /
Ignazio Apolloni (1997). Recenti: l’opera buffa L’histoire
de l’oeuf a’ la coque (2000) e Racconti patafisici e pantagruelici
(2000). La sua visionarietà ri-creativa si libra, con una vigoria
coinvolgente e tumultuosa, in ogni forma di comu-nicazione, in una fluviale
quanto canalicolare espansione, attraverso la fantasmagoria acromatica
di irruenti pieghe corporali e psichiche.
v
top |
|
|
|
Attilio
Lolini
|
|
SFOGLIANDO
IL PASSATO E PER COMPRENDERLO
Sfogliando
i numeri di Antigruppo Palermo e poi di Intergruppo si ha, oggi, l’impressione
di una grande distanza; il mondo “descritto” in quei fascicoli
è lontano anni luce e, noi stessi, rileggendoci, stentiamo a
ravvisarci, anzi non ci riconosciamo per nulla. Poco più, poco
meno di venti anni e la scena è radicalmente mutata, abitiamo
un pianeta completamente diverso. Gli scrittori che erano (ingiustamente)
bersaglio dei nostri corsivi: Sciascia, Volponi, Morante, Fortini, Parise
ecc., più che scomparsi, sono dimenticati o, al massimo, oggetto
di tesi di laurea da parte di qualche studente universitario con interessi
necrofili. La lontananza, vogliamo ripeterlo, dai primi anni ottanta
appare insomma fantascientifica. Antigruppo, intanto, faceva parte di
una costellazione di riviste, fogli, collettivi, oggi del tutto estinti
e dimenticati ma che a quei tempi erano dotati di una vitalità
straordinaria tanto da riguardare, in qualche modo, gran parte del bel
paese. Un’editoria di base, capillare e diffusa, interessava molte
città italiane, da Cuneo a Palermo; nascevano riviste, collane
di poesia mentre esplodeva la “moda” del ciclostile: una
massa imponente di palinsesti poetici distribuiti, per lo più,
per posta e “recitati” nelle così dette letture pubbliche
che ogni assessorato alla cultura che si rispetti promuoveva.
Tra le innumerevoli riviste e rivistine di quegli anni Intergruppo si
distingueva per la cura della grafica e la stampa impeccabile (quasi
del tutto assente in altre imprese del genere legate alla pratica del
ciclostile) ispirate, in qualche modo, ai modelli dell’avanguardia
ortodossa del Gruppo ‘63 (Tam Tam, di Adriano Spatola, tanto per
citare una rilevante testata) o alla neoavanguardia politica, se così
si può dire, delle riviste promosse da gruppi vicini alle esperienze
di Quindici e de I quaderni piacentini. Nel primo numero di Intergruppo,
del 1974, Pietro Terminelli, in quello che rimane – più
che un editoriale – un manifesto teorico della rivista, afferma,
parafrasando Il Manifesto di Marx, che uno spettro si aggira per la
penisola, lo spettro dell’Intergruppo, appunto. La scrittura,
com’era di moda allora, è volutamente difficile ma si delineano
già una pluralità di temi che saranno determinanti nella
storia della rivista: la contestazione degli anni settanta ha messo
a nudo le vecchie accademie e le nuove; si auspica e si lavora per una
cultura sempre più massicciamente demifisticatoria, liberatrice.
A tal proposito si fanno i nomi di Benjamin, Marcuse, Adorno e l’inevitabile
Mao-Tse-toung.
Le polemiche roventi sono indirizzate contro il neorealismo (che per
Terminelli comprendeva anche il buon Pagliarani) e, ovviamente, l’avanguardia
del Gruppo ‘63 ossia lo sperimentalismo di Sanguineti e Balestrini
mentre Giuliani veniva inserito nei casellari del neocrepuscolaresimo.
Posizioni assai vicine a quelle di altre esperienze, specie fiorentine
e catanesi, con le quali l’Intergruppo aveva rapporti assai stretti
anche se Collettivo R, di Luca Rosi (ma non la raffinata Quasi, di Zagarrio
e Favati) e Salvo Imprevisti, di Mariella Bettarini disdegnavano ogni
belluria grafica in favore di una stampa spoglia e francescana. I bersagli
erano, tra l’altro, i così detti intellettuali, specie
quelli di sinistra con i loro fervorini inneggianti alla prudenza, con
un piede nei gruppi e l’altro saldamente posato sulla cattedra
universitaria. Cosa continuano a fare gli intellettuali in Sicilia?,
si chiedeva polemicamente Antigruppo Palermo. Niente, più di
niente, ossia continuano a non esistere o a farsi vivi solo quando c’è
da “grattare” qualcosa. Risfogliando questa rivista si ha
l’impressione di un’autenticità mai truccata, spesso
i bersagli appaiano pretestuosi ma in complesso trapela una ricchezza
linguistica rilevante frutto, anche, dell’abbattimento d’ogni
schema; Antigruppo ospita l’oltranza e non importa se essa entra
in collisione con l’idea stessa della rivista letteraria, anche
quella estremistica e rivoluzionaria. C’è sprezzo delle
buone maniere, di tutte le convenzioni e non è un caso se oggi,
da una lettera di Terminelli, leggiamo un passo dove ci incita a dir
male di tutti, a non guardare in faccia a nessuno.
Si diceva della distanza da oggi; in anni in cui il computer era un
sogno avveniristico, i poeti e scrittori si scambiavano molte lettere,
specchio di un paese travagliato da rivolte di ogni tipo ma avviato
inesorabilmente verso una totale restaurazione, quella odierna, appunto.
La poesia dei giovani (angeli del ciclostile), la poesia operaia, la
poesia delle donne; gli scrittori hanno smesso di fare le belle statuine,
di essere l’ornamento di una cultura accademica e provinciale;
la scrittura diventa politica e scende nelle piazze, si fa slogans e
volantino, inneggia alla rivoluzione. Ma questa non è poesia,
dicevano i poeti laureati, i giovani poetessi reggicoda al seguito di
quelli, ma intanto erano messi in scacco da un clamore che non intendevano
e non volevano capire. Verso la fine degli anni ottanta, quando il potere
torna tutto nelle mani della vecchia istituzione letteraria, verrà
attuata una strategia della dimenticanza; quegli anni non vanno né
studiati né capiti ma solo archiviati. Antigruppo è lo
specchio di quei tempi e non è un caso (a parte i saggi di Giuseppe
Zagarrio e Stefano Lanuzza) che si faccia finta che non sia neppure
esistito come tutta l’esperienza, per esempio, della poesia operaia.
Un pur minimo elenco dei redattori e dei collaboratori di Intergruppo
rimanda ad un’idea di poesia e di scrittura che, oggi, nell’Italia
della restaurazione e del conformismo, potrebbe essere oggetto di studio
e seria riflessione per conoscere meglio anni di generose ed intense
avventure letterarie. A chi ora sfogli queste riviste può capitare
di non intendere quasi nulla delle furiose polemiche degli anni settanta;
anche il Gruppo ‘63 appare del tutto archiviato per non dire dello
stesso Pasolini “politico”. In un editoriale non firmato
dell’ottobre del 1973, si scrive a lungo dell’impegno degli
scrittori di Antigruppo, un movimento che è nato, anzi venuto
su dai movimenti di base delle masse lavoratrici e degli studenti, tende
sempre di più a coinvolgere le masse nella vita artistica e letteraria
dell’Isola. Si elencano, dopo aver riconosciuto il “ciclostile”
come prima alternativa alla stampa ufficiale, una serie di iniziative
contro l’industria editoriale al potere: recitals di poesie e
dibattiti, pubblicazioni di base e cooperativistiche in uno scontro
“linguistico e dialettico” con le strutture mortificanti
e mistificatrici della Sicilia e dell’intera Italia. Contro il
pessimismo ufficiale dei critici borghesi si afferma che la letteratura
non è morta, tanto meno la poesia: questa va cercata nella clandestinità.
La nuova poesia è rivoluzionaria perché non serve la causa
borghese e non è più pensabile che questa possa essere
un prodotto privilegiato di una èlite di intellettuali legati
alla cultura al potere. È notevole, in questo argomentato scritto,
la “fotografia” della cultura siciliana dell’epoca
del resto non dissimile, d’altra parte, da quella di oggi.
Oltre i libelli, le invettive in versi e i palinsesti “tellurici”
diretti contro la così detta borghesia, responsabile d’ogni
crimine e malefatta, Antigruppo, pubblicava anche testi creativi, come
le favole di Ignazio Apolloni, pagine di Mariella Bettarini, poesie
di Andrew Donus, Jack Hirschman, Gianni Toti e perfino un intervento
su Fortini di Gianni Riotta allora scatenato movimentista oltre a scritti,
di sapiente critica, di Nicola di Maio. Tra questi materiali c’è
qualcosa di duraturo, non legato alle polemiche e alle “mode”
correnti, insomma i materiali propriamente creativi appaiono quelli
più riusciti, sottratti – ma non del tutto – alla
furie iconoclaste dei collaboratori e redattori “politici”.
Se si considerano testate simili sparse in tutta Italia (ma Antigruppo
resta un caso a sé) si ha l’impressione che, in quegli
anni, la poesia fosse davvero uscita all’aperto ossia dall’Accademia
e l’Università (che sono poi la stessa cosa), dalle logiche
delle case editrici e fosse diventata davvero uno strumento di comunicazione
diretto a tutti. Veniva liquidato l’Ermetismo e l’avanguardismo
petrarchesco del Gruppo ‘63 per la sperimentazione di un linguaggio
diretto a tutti ed, in modo particolare, alla classe operaia, con risultati
spesso contraddittori e ingenui ma va constatato che, allora, i lettori
e i fruitori di poesia erano infinitamente superiori a quelli d’oggi;
la poesia entrava ovunque anche se, spesso, era “azione”
e comizio. Sfogliando i numeri di Antigruppo, che serbiamo rilegati,
oggi, più che la distanza, sovviene una specie di rimpianto e
di malinconia. Lì sta, in qualche modo, il nostro ritratto di
giovani ingenui e, talvolta, sprovveduti, ma anche il catalogo delle
rinunce, delle piccole viltà che abbiamo accettato diventando
vecchi e sordi all’entusiasmo e alla generosità.
v
v
top
|
|
|
| |
|
Tratto
da La “crisi” delle riviste in Storia generale della letteratura
italiana a cura di Nino Borsellino e Walter Pedullà, Federico
Motta Editore, Vol. XIII, pagg. 97-98
Il
fenomeno più vistoso degli anni Settanta è quello della
proliferazione delle riviste di poesia che si accompagna a una crescente
diffusione della poesia presso un pubblico di massa, per lo meno nelle
forme della spettacolarizzazione (letture pubbliche, festival di poesia
ecc.). Mentre si andavano via via esaurendo le esperienze delle riviste
politiche del decennio precedente (la maggioranza delle testate chiudevano
o assumevano una funzione diversa da quella originaria, come avveniva
per i “Quaderni Piacentini” e “Ombre rosse”)
e gran parte delle riviste letterarie subiva il mutato atteggiamento
verso la letteratura (alcuni periodici, per esempio “Paragone”,
non mostravano di registrare la crisi; altri, come “Il Verri”,
sceglievano la linea critico-teorica sacrificando quasi totalmente la
parte testuale), nascevano decine di nuove testate di poesia: “Periodo
ipotetico” (1970) di E. Pagliarani (che, a differen¬za di
altre riviste, cercava di coniugare discorso culturale e discorso politico),
“Tam Tam” (1972 di A. Spatola e G. Niccolai che, fin dai
primi numeri affiancata dalla ricerca saggistica di “Altri Termini”
(1972) di F. Cavallo, rilanciava il dibattito e il nuovo corso poetico,
“Almanacco dello specchio” (1972) di M. Forti, “Quinta
generazione” (1973) di G. Piccari, “Pianura” (1974)
di S. Vassalli che proseguiva l’esperienza di un altra testata,
“Ant.Ed”.
Una linea specifica era poi rappresentata dai fogli che, in vario modo,
si collocavano entro l’esperienza esoeditoriale, che esprimevano,
cioè, fin dalle loro modalità di produzione e di stampa
una posizione antagonista rispetto all’editoria tradizionale.
L’uso del ciclostile veniva teorizzato come liberazio¬ne dalla
tipica alienazione del poeta all’industria culturale (gli stessi
Zanzot¬to e Roversi avevano prodotto testi ciclostilati o in edizione
artigianale) e come tratto di identità politica e di contestazione
del nuovo ritorno all’ordine. “Téchne” (1969)
di E. Miccini e “Collettivo r” (1970) di L. Rosi, F. Manescalchi
e U. Bardi proponevano i primi esempi di questo tipo di foglio, seguiti
da “Quasi” (1971) di G. Zagarrio e G. Favati e da “Salvo
Imprevisti” (1973) di M. Bettarini. Si tratta di riviste (o antiriviste,
come allora amavano definirsi) tutte nate a Firenze, città che
rappresentava per diversi anni la punta avanzata del dibattito sulla
possibilità di una poesia effettivamente alternativa, che distruggesse
i codici comunicativi borghesi (un’ipotesi che era stata già
della neoavanguardia, ma che era stata dilapidata) e le forme della
tradizione letteraria sclerotizzata, e che recuperasse nella prassi
poetica una forma di impegno civile e politico.
Esperienze simili, tese alla riaffermazione di una nozione di impegno
in letteratura e frutto di un lavoro di gruppo che veniva sperimentato
attivamente anche nel territorio, avvenivano contemporaneamente in Sicilia
ove, accanto alla cosiddetta “scuola di Palermo” (con R.
Di Marco e G. Testa) più vicina all’opzione neoavanguardistica,
operava attivamente l’Antigruppo, il cui nucleo iniziale comprendeva
R. Certa, C. Cane, G. Diecidue, N. Scammacca, P. Terminelli ai quali
si aggiunse poi S. Calì. Inizialmente l’Antigruppo ebbe
il suo organo in “Impegno 70” del 1971 (diventato poi “Impegno
80”); successivamente, nel 1973, da dissensi interni nel gruppo
nasceva l’Antigruppo Palermo di Terminelli e Apolloni, che dal
1976 avrebbe assunto il nome di Intergruppo.
L’esperienza esoeditoriale verrà dichiarata consumata già
verso la metà del decennio (anche se persisterà una forma
marginale di underground selvaggio); riprenderà parzialmente
nel 1977 quale supporto creativo-politico al Movimento studentesco e
nei primi anni Ottanta come strumento editoriale po¬vero delle tante
riviste e rivistine del periodo, riproponendo, con qualche variante,
i problemi dell’ uso privato del ciclostile e dei gruppi letterari.
Quello del lavoro di gruppo (e, dunque, della rivista quale prodotto
di una esperienza di un soggetto collettivo o, comunque, di più
soggetti uniti da una progettualità con elementi comuni) è
un altro degli elementi caratteristici e talora centrali in molte testate
degli anni Settanta. La nozione, di origine sessantottesca, di collettivo
o gruppo di base subisce nelle riviste di poesia una accentuazione nel
senso del laboratorio, a volte con connotazioni politiche (soprattutto
all’inizio del decennio) che progressivamente si diluiscono per
lasciare il campo a una pura officina, essenzialmente di poesia. Esempi
cronologicamente e morfologicamente diversi, oltre alle già citate
esperienze dell’Antigruppo siciliano, possono essere considerati
“Niebo” (1977) di M. De Angelis, “Il Foglio”
(1980) della casa editrice Guanda, legato alla Società di Poesia,
e il “Bollettino del Laboratorio di poesia” (1981) di E.
Pagliarani, prodotto dal Laboratorio di poesia, che nascevano, appunto,
da formule e da pratiche diverse di lavoro collettivo.
top |
|
|
|
Ugo
Piscopo
|
|
|
Scritto
apparso su Ippocrene nel 2011
Dialogo
(quasi) a bocca chiusa
Dicono
i grammatici normativi che i verbi sono di due tipi: transitivi e
intransitivi.
L’esperienza dice diversamente: che quasi tutti i verbi (e la
verbalità) sono intransitivi.
Tali, ad esempio, parlare, insegnare, educare, scrivere & co.
Esistono anche i verbi transitivi, certamente: ma trattasi di eccezioni.
Che, in quanto tali, confermano la regola. Tali, ad esempio, tacere,
ricordare, ascoltare-realmente, inventariare, analizzare, interpretare,
pazientare certosinamente e attendere. Non godot, ma il sottrarsi
del senso delle vicende. Perché queste sono in quanto sono,
ma essendo, immediatamente si rovesciano nel dicibile, che è
interfaccia dell’indicibile.
Intanto, veniamo a noi. Sono legittimato, nei confronti di antigruppo,
a parlare di noi, come sottolineavano gli espressionisti tedeschi
criticamente attestati sul versante del wir sind – wir waren.
Ma posso dire di noi pressoché come un testimone auricolare
in materia di quanto egli abbia potuto sentire o gli sia stato fatto
sentire.
Comunque, anche la condizione di testimone non è casuale, come
sostengono gli
psicosomatici. Uno non si trova mai senza un suo consenso profondo
in un luogo, in/presso un accadimento.
Perciò vengo ai fatti. Che sono di collusione ideale e un po’
anche materiale: partim et passim.
Non ricordo più come ci conoscemmo. Se ci fu uno che ci presentasse,
perché è nel codice antropologico che ci sia sempre
qualcuno che faccia da anello d’interpretazione e da garante.
O se fu lui una sera a chiamarmi da Palermo e ad avviare una di quelle
filippiche che non finiscono mai, ma proprio non finiscono mai. La
notte avanzava e lui continuava, fieramente, sempre più incalzantemente.
Progressivamente la telefonata mi intrigava, mi strappava il consenso.
La voce
dell’interlocutore, ovvero dell’oratore si identificava
a mano a mano con quella di un gruppo o, meglio, di una città.
Era Palermo che parlava in un italiano dalle forti inflessioni palermitane,
ma con sue ragioni vigorose, con icasticità etiche che venivano
disoccultando mistificazioni e disvalori, che chi viveva a Napoli,
in maniera partecipata come me, non poteva non capire.
Non solo Palermo s’era messa a parlare a Napoli, in uno sfogo
più che plausibile fra due capitali del malessere e delle contraddizioni
nazionali, ma a Palermo un po’ ci abitavo.
Lì ho avuto l’editore a me più caro, nel cui catalogo
egli mi ha consentito generosamente di occupare per decenni uno spazio
di ampio respiro. Per sovrappiù, per chi come noi di quel tempo
sapeva che la rivoluzione era all’angolo e che era ineludibile
entrare nel cambiamento sull’onda delle insopprimibili attese
del Sud, non poteva non saldarsi una solidarietà intellettuale
meridionalmente magnatica.
Chi era questo impetuoso e coinvolgente animatore di passione? Chi
poteva essere, se non il poeta di Antigruppo impegnato programmaticamente
nell’antagonismo e totalmente vocato alla mimesi dell’antitesi
che assume il vissuto e la microstoria a esemplificazione delle storture
universali?
Era Pietro Terminelli in persona.
In quel periodo, era la fine degli anni Sessanta, per parte mia mangiavo
anti e
letteratura, anti e politica, anti e giornalismo, anti e scuola. Davo
consenso senza riserve ad “Ant ed” di Sebastiano Vassalli.
E quando i carabinieri andarono a casa sua a fare accertamenti su
quel foglio, io gli scrissi prontamente che ero disposto a trasferire
a Napoli l’iniziativa. Nel campo delle ricerche letterarie stavo
lavorando alla prima monografia, che vide la luce presso Mursia a
Milano nel 1973, dedicata a Alberto Savinio, un geniale eccitatore
del nuovo sul filo di uno straniante umorismo e di un’inquietudine
scarnificante e spietata verso le certezze di comodo.
Poco tempo dopo quella prima interminabile telefonata, Pietro venne
a trovarmi a Napoli e fu ospite per un giorno a casa mia. I miei figli
a tavola si divertirono immensamente ad ascoltarlo e se ne impressero
nella memoria gesti, gutturalità, impasti fonici e per anni
li riprodussero in enfatica teatralità. Ancora adesso, il più
piccolo, che ha un forte senso della plasticità ed è
cresciuto, se ne ricorda e induce un sorriso complice nella madre.
È il segno che era un personaggio scenograficamente, cioè
anche scenograficamente, non insignificante.
Pietro mi aveva portato in dono fogli, tracciati, antologie, fascicoli
pubblicati nella
rivista. Mi parlò di tanti amici e nemici. Io cercavo di appuntarmi
mentalmente quelli che ricorrevano più frequentemente nel bene
e nel male.
Cercavo anche di farmi un’idea precisa della situazione. Capii,
così che il discorso si alimentava di fortissime tensioni.
Notai con piacere che tutti gli attori erano impegnati allo spasimo
a marcare la propria identità e a farla riconoscere anche fuori
dell’isola, a Firenze, a Napoli, altrove. Fuori dell’isola,
però, si muovevano e allacciavano cinghie di trasmissioni di
relazionalità e di circolazione di idee essenzialmente due
Dioscuri. Uno era naturalmente Pietro in persona. L’altro era
Ignazio Apolloni.
Quando volli conoscere più in dettaglio i rapporti che erano
stati stabiliti con quelli della “scuola di Palermo” (Di
Marco, Perriera, Testa), Terminelli reagì come a una provocazione.
Nell’ottobre del 1963 dovevo essere anch’io a Palermo
nella conta e ne||’unzione dei catecumeni.
Conservo ancora una cartolina d’invito di Luciano Anceschi:
“Ci vediamo in ottobre a Palermo”. Dove, poi, non andai.
Ma con Anceschi non cessarono i rapporti. E parlammo anche dei siciliani.
Per Pietro fu come se avessi nominato un gruppo satanico o giù
di lì. Esplose in scongiuri, formule apotropaiche, denunzie,
denunzie, denunzie. Nel positivo e nel propositivo, intanto, mi veniva
significando che la letteratura non è finzione, non compromissione,
non calcolo, ma solo, se è viva e autentica, equazione e simbiosi
di incandescente eticità e di espressione di antitesi. Si veniva
anche appoggiando ad argomenti ovvero a tesi classiche del materialismo
dialettico, ma più lo confortava a procedere nella tensione
ideale l’esempio dei poeti dei nostri giorni.
Quando si imbarcò sul traghetto per Palermo in serata, Pietro
si portava soddisfatto in Sicilia (nell’ideale carniere) il
mio consenso, la mia simpatia, dei miei versi da pubblicare e che
mi pubblicò sulla rivista.
Seguirono scambi di lettere, telefonate, altre visite di Pietro a
casa mia. L’ultima volta venne a trovarmi in compagnia di Ciro
Vitiello, quando si stava per lanciare “L’involucro”.
Intanto, si era venuto stringendo un dialogo anche con Ignazio Apolloni,
ma più cool, più squisitamente letterario. Ignazio aveva
cominciato a inviarmi in regalo i suoi libri-oggetto, sketch-poesie
e provocazioni di sinestesie del linguaggio iconico e di quello verbale.
Ne seguivo lo svolgimento, osservando concordanze futuriste e audaci
contattazioni del fumetto e del cinema.
Ma improvvisamente un giorno mi scrisse una letteraccia, lunga, articolata,
con tutti gli spazi bianchi occupati. Aveva acquistato e letto un
mio libro, Novecento e tradizione, dove io cercavo di analizzare il
sorgere e l’affermasi della tradizione del nuovo nella poesia
italiana del XX secolo. Era la seconda edizione di tracciati di un
ciclo di mie conferenze tenute a meta degli anni Sessanta all’Istituto
Italiano di Cultura di Tripoli.
Ignazio mi accusava di integrazione nel sistema e mi disconosceva
come amico e
compagno di strada, di svendita dell’ “anti”. Per
lui passato presente e futuro andavano giudicati unicamente secondo
la legge della nostra irriducibilità all’ordine costituito,
che era l’irriducibilità tout court.
Gli risposi con delle precisazioni e distinzioni storiche e filologiche.
Ma credo che la risposta non gli facesse né caldo né
freddo perché non me ne dette riscontro. A lui bastava aver
segnalato all’amico la caduta di impegno ed essersi sfogato.
Le sue incazzature sono eventi: hanno una nicchia in quel momento
e in quello spazio, poi vengono affidati a se stessi.
“Chi vivrà vedrà”, dice loro Apolloni e
va appresso a cercare altre nicchie da riempire con la sua insopprimibile
tensione creativa e con la sua follia.
Sostiene Pirandello che dentro ognuno batte una corda pazza. Io credo
che dentro
Apolloni batta più di una corda pazza. Così, l’originalità
è assicurata.
Originale, Apolloni è originalissimo. Non sto a tracciarne
un profilo, per rispetto della natura della nota. Ma qualche glossa
almeno va apposta sulla presente stagione.
La quale continua a mantenere fede, molto generosamente, alla poetica
dell’”anti” sottoscritta coralmente nel gruppo negli
anni Sessanta.
L’indocilità non solo all’aulico, al curiale, all’accademico,
ma anche al confortevole e al gradevole che tanto spesso si coagula
e gratifica autori e fruitori della comunicazione media e perfino
di quella bassa e degradata, dove non manca chi si rifugi per dileggio
delle misure e convenzioni alte, produce sciami sismici di annichilimento
di tentativi e tentazioni di addomesticamento alla cosa immonda che
è il sistema. Il non senso si compiace di appostarsi fin dall’inizio
per poi fare sberleffi al lettore nel corso dei lavori o alla fine
degli stessi, ridendo della sua ingenuità a non essersene accorto
da subito. Il divertimento, di etimo palazzeschiano, che pertanto
rivendica il diritto sia di scollegarsi aprioristicamente da implicazioni
ideologiche e moralistche, sia di aggirarsi in allegria intorno a
ogni spunto o pretesto ludico, scompiglia e sconvolge le trame supposte
o supponibili delle vicende.
Questo è oggi come ieri, anzi forse più di ieri, perché
Apolloni, col passar del tempo, rende ancor più lieve e giocosa
la disponibilità all’avventura ideale (e forse anche
esistenziale).
Perché appartiene alla razza di quelli che nascono non per
restare giovani, ma per essere ogni momento, in ogni prova, giovani
sempre.
Ma il gioco, oggi, è per lo scrittore molto più sottile
di prima e i veleni che egli
dissemina nel suo fare sono molto più insidiosi e tenaci. La
strategia stessa della poiesis è più astuta, potendosi
Apolloni giovare del dialogo che viene intrattenendo con dei volponi
della letteratura come Gramigna e Finzi.
Il segno più tangibile degli acquisti coscienziali sul versante
della mimesi è nell’opzione, che non possiamo dire definitiva,
perché niente è definitivo nella storia e tanto meno
per il nostro Ignazio, per la narrativa, che è sempre acuminatamente
“anti”, ma che in questi ultimi anni è sempre più
pervasa come attività fondamentale e fondamentalmente verbale,
anche se sollecitata da tecniche verbali dei nuovi media, dal cartoon
alla tv e al computer. Sembra proprio che Apolloni finalmente si sia
deciso a prendere cittadinanza, ma anche residenza, nel romanzo, nella
novella, nella favola.
Ma vediamo quali scherzi perversi egli continua a fare a danno (ma
anche a vantaggio) delle istituzioni letterarie.
Partiamo dalla favola, che a un siciliano riesce spontanea, perché
“discende per li rami”.
La predisposizione sorgiva alla fabulazione e alla favolistica non
cerca, in Apolloni, contaminazioni con l’esotico e la sensualità
mediterranea e saracena, come ad esempio in Bonaviri (anche lui siciliano,
non a caso). L’autore non si lascia implicare né antropologicamente,
né sociologicamente, né subliminarmente.
Egli è deciso a servirsene, perché è venuto scoprendo
che in tale inclinazione possiede una risorsa decisiva. Ma stabilisce
di servirsene senza compiacimenti, al di là degli schemi, perché
non può farne a meno.
Modernamente, cioè in senso innovatore e sperimentale insieme,
va a saggiare le
possibilità della favola prima nell’avvicinamento delle
punte con il fumetto alla Charles Schulz, alla Johnny Hart (l’autore
di B.C.), alla moda di Al Capp. Successivamente, dopo e durante frequentazioni
delle “anime” giapponesi e di Tiziano Sclavi, rilancia
la favola e il racconto per i giovanissimi con provocazioni nichilistiche.
Il ricorso alla favola è strumentale apertamente alla registrazione
della morte della stessa.
Si apra a caso una pagina di Capellino (1991), la prova più
impegnativa e significativa di Apolloni nella narrativa per ragazzi,
e si troveranno a iosa periodi lunghi, addensarsi di materiale semantico
non tarato sulle capacita d’intelligenza (e di suggestione)
di chi è in fase di sviluppo, rinvii a esperienze letterarie
e artistiche sofisticate della modernità, riporti linguistici
da milieu sociali e culturali raffinati. In pratica la favola c’e
ma solo promessa, allusa, appena suggerita. Essa si cerca come fruitore
non il bambino o il ragazzo vero, ma l’adulto mentalmente maturo
e vaccinato ai mali della vita e agli scherzi del linguaggio, in cui
tuttavia abiti l’albale innocenza degli inizi.
Questo lettore in Capellino troverà deliziose occasioni di
sognare a occhi aperti e
riscoprire il piacere dell’invenzione e dell’intrigo.
Analogo pubblico cercava Mozart per le sue favole settecentesche o
Ciajkovskij con Il lago dei Cigni e lo Schiaccianoci. Ironia, svuotamento
dall’interno di ogni contenutismo narrativo, trasgressione,
giuoco
crudele al massacro delle convenzioni, ma intrisi di brio creativo,
animano egualmente le opere non favolistiche. Gilberte (1994), ad
esempio, un libro di 563 pagine, è un romanzo anti-inter-meta.
Come acutamente osserva Gilberto Finzi, in esso, “come in una
lezione del grande Lacan, il testo sa molto di più di quanto
non sappia il suo autore”. La complessa, intrigata, sfaldata
vicenda rappresentata implode in mimesi del caos che incombe e circola
non solo sul mondo contemporaneo, ma sul mondo in sé e si fenomenizza
nell’avvolgente, gratuita narratività, anonima eterna,
dettata da una “bouche d’ombre”.
Ormai, l’accettazione di trovarsi e guardarsi nella letteratura
come specchio della realtà e intersezione della stessa, è
piena. La sottoscrizione è in Racconti patafisici e pantagruelici
(2000). Qui tutto il gusto dello scherzo e dello scherno è
avvolto nella consapevolezza che in questione non è solo il
fantasma dell’oggetto, ma il destino stesso di chi parla insieme
con quello del corpo della parola.
È un punto alto toccato da Apolloni. Forse il più alto
e persuasivo. Ma un punto anche di approdo dell’agonismo di
Antigruppo-Intergruppo.
Napoli, novembre 2001
Ugo Piscopo
top
|
|
|
v
|
|
| |
|
v
|
|
|
| |
|
|
|
| |
v
|
|
|
|
| |
v
|
|
|